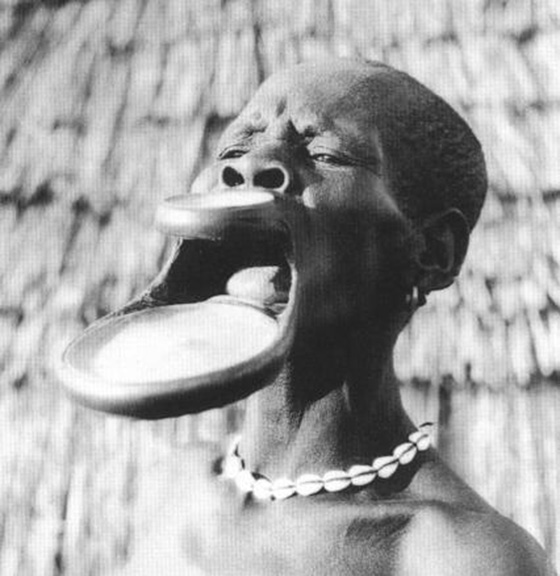Didone, o Elissa o Elisha, era figlia di Belo o Mutto, re di Tiro e nipote e poi anche moglie di Sicheo o Sicarba. Alla morte di Belo salì al trono insieme a suo fratello Pigmalione ma quest’ultimo, avido di potere e geloso delle ricchezze del cognato- zio, uccise Sicarba. Didone seppe del delitto solo quando il marito le apparve in sonno e le rivelò la causa della sua morte.
Forse per evitare la guerra civile, Didone decise di fuggire con un gruppo di fedeli e con i tesori di Sicarba, ma non aveva navi e allora chiese a Pigmalione un incontro per arrivare ad un accordo e il fratello mandò navi e marinai a prenderla. Ma di notte Didone, aiutata dai suoi, caricò di nascosto l’oro a bordo e mise sacchi colmi invece di sabbia sul ponte facendo credere che contenessero tutto l’oro del marito.
Dopo che le navi furono salpate, Didone gettò i sacchi di sabbia in mare e gli uomini di Pigmalione non osando tornare da lui senza il tesoro, fecero rotta verso Cipro dove la regina fece trovare sulla spiaggia 80 ragazze disposte a seguirli ovunque. I marinai seppero poi che il tesoro era ancora a bordo e con l’oro e le ragazze seguirono Didone nell’impresa di fondare una nuova città.
Approdata sulle coste settentrionali dell’Africa, fu accolta benevolmente dagli abitanti che la chiamarono “Didone”, cioè “la fuggitiva“. Le posero però la condizione di poter acquistare solo tanto terreno quanto ne potesse circondare una pelle di bue, allora la regina la fece tagliare a strisce così sottili da circondare una collina sulla quale fondò Cartagine.
La leggenda più antica narra poi che un re africano si innamorò di lei e che Didone si suicidò per non sposarlo. Virgilio riprese la leggenda nel IV libro dell’Eneide e confermò la fuga di Didone da Tiro e la fondazione di Cartagine, ma attribuì il suicidio al suo amore nei confronti dell’eroe troiano Enea.
Narrò infatti che quando Enea giunse naufrago a Cartagine, la regina si dimostrò molto generosa nei confronti dell’eroe troiano e dei suoi compagni e li accolse nella sua reggia. Per opera di Cupido, nacque poi fra Enea e Didone un profondo sentimento e lei, riuscendo a superare il senso di fedeltà e di affetto per il primo marito, si abbandona al nuovo amore.
Poi però Giove per volere del Fato mandò in apparizione ad Enea Mercurio, il messaggero degli dei, che ricordò all’eroe troiano che la città da fondare non era in Africa ma in Italia e lo sollecitò a partire.
La regina, con intuito femminile, si accorse dei preparativi per la partenza e, disperata, lo supplicò di non andarsene ma Enea, pur ringraziandola dell’accoglienza ricevuta, non si fece commuovere dalle suppliche perchè doveva portare a compimento i doveri che il Fato gli aveva assegnato.
Quando la regina vide le navi troiane allontanarsi da Cartagine, pazza di dolore si tolse la vita con la spada dell’eroe. Si diede la morte in modo virile e abbandonò la vita tra la pietà degli dèi e la commiserazione del suo popolo, che accompagnò l’evento nel pianto, come fa il coro di una tragedia. Con il sacrificio di Didone si ristabilì l’ordine e il destino di Enea si poteva compiere.
Quando Enea, nel VI libro dell’Eneide, scese poi nel regno dei morti con la Sibilla per conoscere i suoi discendenti, vide tra le altre anime anche quella di Didone che si trovava nei Campi del Pianto, dove vi erano i morti per passione d’amore.
Enea cercò invano di giustificarsi con lei per essere stato la causa della sua morte, ma la regina tenne gli occhi fissi al suolo, non gli rispose ed infine si consolò tra le braccia del suo ex marito Sicarba che ricambiava il suo amore.